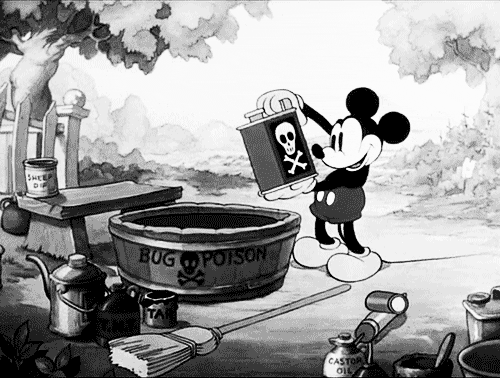BOILER #13
Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.
Ciao!
In questo numero: nella parte open un mini-saggio sul CINEMA SALGARIANO.
Nella parte su abbonamento, La Biblioteca dei bestseller dimenticati si occupa di L.T. Meade, una delle scrittrici più prolifiche di sempre (circa 300 romanzi!), e in particolare sul suo romanzo per ragazze A World of Girls (1886) storia di una scuola femminile con complicazioni mystery. Strana figura, quella di Meade, decisamente anticonformista e militante femminista, ma anche anti-omosessuale, anti-semita e anti-vaccinista.
Comincia così il SECONDO ANNO di BOILER. Gli abbonati dal numero uno ricordino che l’abbonamento è annuale e, in base alla data di sottoscrizione, potrebbe essere scaduto.
Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.
I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.
Buona lettura!
Gianfranco
PER UNO STUDIO DEL CINEMA SALGARIANO
di Gianfranco Manfredi
1. Premessa
Sono una cinquantina i film dichiaratamente ispirati ai romanzi di Salgari. Molti di più considerando quelli che ne riprendono ambienti, situazioni, atmosfere e tratti dei personaggi. Una cifra più che ragguardevole: all'incirca la metà, per fare un confronto, dei film ricavati dai racconti di Edgar Allan Poe, uno degli scrittori più trasposti sullo schermo. È stato notato da molti critici che la narrativa salgariana era predestinata al cinema, di cui anticipava molte caratteristiche fondanti: scenari esotici, trame avventurose ricche di colpi di scena, ritmo incalzante, dialoghi essenziali, funzionali alla storia, ma vivacemente coloriti. Eppure ci sarebbe molto da discutere circa l'influenza del "salgarismo" sul cinema italiano. La critica cinematografica considera, da sempre, il cinema salgariano come genere minore nel contesto della produzione nazionale. Si può dire dunque che questo cinema condivide la stessa sorte della narrativa salgariana, valutata, a dirla piatta, come di Serie B, per i suoi connotati di racconto popolare e in particolare per l'influenza sugli adolescenti: una sorta di esperienza pre-letteraria da affiancare a quella costituita dalla lettura dei fumetti. Le cose, in verità, non stanno esattamente così e una rassegna dei film salgariani può da questo punto di vista essere illuminante. Premetto di non aver visto tutti questi film, dunque queste mie note non saranno che una traccia, augurandomi che vengano compiuti studi più approfonditi su questo vero e proprio fiume carsico tuttora trascurato dagli studiosi del cinema italiano. Persino un esploratore del cinema sommerso come Marco Giusti, nel suo sterminato Dizionario Stracult (Sperling & Kupfer, 1999) cita soltanto tre o quattro film salgariani.
2. Il cinema salgariano d'epoca fascista
Il rapporto di Salgari con il cinema italiano inizia clandestino, con il monumentale Cabiria (1914) di Giovanni Pastrone, che al di là delle didascalie di Gabriele d'Annunzio cui il film venne accreditato per intero, richiama non poco il romanzo salgariano Cartagine in Fiamme, pubblicato a puntate nel 1906 e in volume due anni dopo da Donath Editore. Altri riconoscibili echi salgariani risuonano, a quanto risulta dalle critiche d'epoca, nel film purtroppo perduto Il naufragatore o La vendetta del Pirata (1915), unica pellicola di avventura marinaresca di Emilio Ghione, divenuto divo con il personaggio dell'apache parigino Za-la-Mort. Per quanto se ne sa, la vicenda narrata dal film di Ghione è contemporanea, non in costume, se ne può quindi desumere che Salgari ne costituisca un riferimento di clima avventuroso più che sostanziale. In modo diverso, sia D'Annunzio che Ghione aspiravano al Sublime. Un franco omaggio a uno scrittore popolare come Salgari poteva disturbarli. È negli anni '20 che Salgari viene sdoganato, in una serie di corti opera di Vitale De Stefano, già attore in Cabiria nei panni di Massinissa. La serie inizia nel 1920 con il trittico Il Corsaro Nero, La Regina dei Caraibi e Jolanda, la figlia del Corsaro Nero e prosegue nell'anno successivo con Gli ultimi filibustieri, Il Corsaro Rosso e Il Figlio del Corsaro Rosso. Al Corsaro Rosso dedica un film, nel 1928, anche Rodolfo Ferro, film che resta però incompiuto. Da citare anche un film piratesco non direttamente riconducibile a Salgari, ma estremamente significativo: La bella corsara (sempre del 1928) di Wladimiro de Liguoro, protagonista Rina De Liguoro, sua moglie, già interprete di Messalina (1923) di Enrico Guazzoni e del kolossal Gli ultimi giorni di Pompei (1926) di Carmine Gallone e Amleto Palermi. L'attrice vuole fortemente questo film che le consente quel protagonismo da vamp che oltreoceano aveva fatto la fortuna di Theda Bara. Accanto alla De Liguoro, il co-protagonista maschile Bruto Castellani ricorda nel fisico, e mima nel trucco e negli atteggiamenti Douglas Fairbanks nel film di due anni prima, The Black Pirate, nel quale il divo americano, prototipo dell'attore "fisico", interpretava il personaggio del Duke of Arnoldo, dunque vagamente italico, divenuto pirata per vendetta. Ignoro se nella creazione di questo personaggio, Fairbanks, autore anche dello script, avesse presente il Corsaro Nero di Salgari o, com'è assai più probabile, gli scorridori del mare di Sabatini, da cui Frank Lloyd aveva già tratto ispirazione nel 1924 per la prima versione cinematografica di The Sea Hawk. D'altro canto, la sua interpretazione che codifica il carattere del Pirata come allegro avventuriero, eternamente fanciullesco, dal sorriso contagioso e dalle innocue bravate, più acrobata che guerriero, è quanto di più lontano ci possa essere dal carattere spiccio, nevrotico e funebre del cavalier Emilio di Roccanera, Signore di Ventimiglia. La bella corsara (film sopravvissuto che appartiene alla collezione della Cineteca di Bologna) rimarca due fondamenta del genere piratesco che vanno al di là delle intenzioni di Salgari: 1. Il ruolo della donna avventurosa, sola in un universo maschile, naturalmente seducente quanto pronta a impugnare la spada. Il debito di questa figura con il personaggio di Jolanda è evidente, ma le caratteristiche sexy ne vengono accentuate. Jolanda, nel romanzo a lei dedicato, è «una bellissima fanciulla di quindici o sedici anni», nei film, la sua età è decisamente più matura. Si presenta «con una mossa fulminea, slanciandosi fuori dall'alcova» ritratto che già simbolicamente ne definisce il temperamento e in aggiunta alle caratteristiche fisiche «alta e flessibile come un giunco, dalla pelle pallidissima», oltre che somigliantissima al padre, rimarca un carattere androgino difforme dall'immagine cinematografica delle tante Belle Corsare; 2. Una certa impronta latina (in Fairbanks, come negli eroi di Valentino), colorisce l'Eroe di un esotismo giocosamente pittoresco, modello che condurrà lontano, fino allo zingaresco corsaro caraibico di Johnny Depp (ma come vedremo, con altri risultati). L'invenzione di questo personaggio la si deve più a Sabatini che a Salgari ed è ben sintetizzata nel bellissimo incipit di Scaramouche: «Era nato con il dono della risata e la sensazione che il mondo fosse pazzo». Dal punto di vista storico-critico, il propendere verso questo genere di avventura, ben diversa dal peplum, ma parallela ad esso, non dipende affatto da una scelta culturale riconducibile alla visione fascista dell'avventura, quanto dal tentativo, in un periodo di crisi produttiva, di risollevare le sorti del cinema italiano, mutuando film e personaggi di successo da Hollywood. Questa è una traccia importante per comprendere i ritorni del tema piratesco nel cinema italiano, ritorni quasi sempre motivati dall'inseguimento di mode americane, e solo in seconda battuta dal riappropriarsi dell'eredità salgariana. Se non si intende questo aspetto, si finisce in spiacevoli equivoci, primo dei quali, appunto, lo sviante collegamento tra epica salgariana e fascismo. Di questo presunto legame, è interessante testimonianza un articolo pubblicato da Ercole Patti sul Corriere della Sera del 27 aprile 1970. Lo scrittore, rievocando memorie personali, vi sostiene che durante il fascismo i romanzi di Salgari erano i prediletti dal cinema, come alternativa ai film dei Telefoni Bianchi. Così spiega il fenomeno: «Venivano scelti per sfuggire ai controlli della censura e anche perché il coraggio e lo sprezzo del pericolo dei personaggi dell’uomo di mare veronese erano ben visti nelle alte sfere. Anzi ci fu un momento in cui vari gerarchi (propugnatori dell’esistenza “scomoda” e pericolosa) consideravano Salgari come loro maestro di vita. Bastava questa aria di simpatia del regime per quel genere perché gruppi di grossolani registi si buttassero a corpo morto sulle storie salgariane. Corsari neri, corsari rossi, corsari verdi, figli e figlie di corsari neri verdi e rossi, leoni di Damasco, tigri del Bengala, popolarono gli schermi italiani». Di seguito, Patti racconta di una sua visita agli stabilimenti Scalera, tra i set popolati di attori e comparse in costume da filibusta. È chiaro dal riferimento che Patti sta parlando degli anni '40. Nel corso degli anni '30, era apparso Il Corsaro Nero (1936) di Amleto Palermi, ma la febbre piratesca è successiva ed è tutta (o quasi) salgariana: La Figlia del Corsaro Verde e I Pirati della Malesia (entrambi del 1941) di Enrico Guazzoni; Le due tigri (1941) di Giorgio Simonelli; Il Figlio del Corsaro Rosso e Gli Ultimi Filibustieri (entrambi del 1942) di Marco Elter. Si aggiungono i salgariani, ma non pirateschi, Capitan Tempesta e Il Leone di Damasco (entrambi del 1942) di Corrado d'Errico con Carla Candiani come protagonista, e I cavalieri del deserto (Gli Ultimi Tuareg) (1942) di Osvaldo Valenti (film rimasto incompiuto). E in Messico, nel 1944, il regista Chano Urueta con il suo El Corsario Negro, protagonista Pedro Armendàriz, offre il primo omaggio latinoamericano a Salgari. Ma torniamo al repertorio italiano per chiederci se davvero questi film, al di là delle letture giovanili dei gerarchi, incontrassero la simpatia del regime. Entro nel tema per uscirne subito, in quanto le letture ideologiche di Salgari (e ce ne sono state anche di opposte) non costituiscono il tema di questo articolo. Mi limito a rilevare, di nuovo, che una simile scelta di genere ha a che fare con dinamiche commerciali riferite al cinema di Hollywood e in particolare allo straordinario successo dei film pirateschi, da The Buccaneer (1938) di Cecil B. De Mille, a The Black Swan (1942) di Henry King con Tyrone Power, tratto da Rafael Sabatini, fino ai blockbusters di Errol Flynn: Capitan Blood (1935), The Sea Hawk (1940), Against All Flags (1952), passando per il super-classico The Spanish Main (Nel mar dei Caraibi, 1945) di Frank Borzage. Cinematografia da inserire, tra l'altro, nel più ampio contesto delle avventure di cappa e spada. È un deplorevole errore ricondurre al fascismo un filone narrativo di tutt'altra origine e di così lungo periodo. I riferimenti letterari principali di questo cinema stanno nei romanzi di Sabatini (italiano anche lui, nato nel 1875 a Jesi) predominanti rispetto al filone parallelo dei film ispirati a L'isola del Tesoro di Stevenson. In questo contesto ottocentesco va inteso il lavoro di Salgari, il che rende grottesco qualsiasi collegamento all'epica fascista. La politica culturale fascista nella sua totalità, da quella avanguardista della prima ora a quella nazionalistica e celebrativa di regime, fu contrassegnata da una precisa volontà di distacco rispetto ai valori epico-romantici dell'ottocento e alla narrativa popolare di quell'epoca, vista sempre con sospetto, dal regime, per i contenuti anarcoidi, libertari, cosmopoliti e anticoloniali in essa e da essa ampiamente sparsi. Nel caso di Salgari, oltretutto, sono ben documentate le censure e aggiustamenti di cui furono oggetto da parte del Minculpop le riedizioni dei suoi romanzi. Risulta infine falso quanto conclude Ercole Patti nel citato articolo e cioè che dopo il fascismo, Salgari scomparve dagli schermi. Accadde invece, come vedremo, l'esatto contrario.
3. La rifondazione salgariana degli anni '50
Nel 1951 esce La vendetta del corsaro di Primo Zeglio, nuova versione de Il Corsaro Nero. Il regista durante il fascismo era stato collaboratore di Mino Maccari e Leo Longanesi per le riviste «Il Selvaggio», «L'italiano» e «Omnibus». Era stata opera di Zeglio una raffigurazione satirica in cui si vedeva Hitler innaffiare un campo da cui spuntavano elmetti prussiani, e, sotto, la scritta: Son tornate a fiorire le rose. Apparve spericolatamente su «Il Selvaggio» nel 1935, in pieno asse Roma-Berlino. Nel dopoguerra Zeglio collaborò con «Il Mondo» di Pannunzio e la «Fiera Letteraria», ma si dedicò soprattutto al cinema di genere, con una particolare predilezione per i film di cappa e spada. In seguito contribuì con Sergio Leone alla fondazione del western italiano. Nulla di nostalgico, dunque, a monte della sua prima scelta salgariana, quanto meno non di Nostalgia di Regime si trattava, casomai di una volontà di recupero di un filone popolare radicato nell'ottocento pre-fascista.
Da analogo e più ampio proposito rifondativo fu animato Mario Soldati che nel 1952 riportò sullo schermo I tre corsari e Jolanda la figlia del Corsaro Nero. Su questa fase del cinema di Soldati, scrive Luca Malavasi: «Le traduzioni ottocentesche sono quelle che meglio istruiscono sul senso profondo dell'operazione soldatiana. Riprendendo Fogazzaro e Bersezio, l' "universale" Balzac e il più ludico Salgari, scorciandoli, ma rispettandoli, Soldati contribuisce a rendere nuovamente disponibile (di nuovo e in modo nuovo) una serie di testi in cui riconosce, in primo luogo, un territorio comune e condiviso di esperienze, valori, immagini, simboli - un territorio "popolare" italiano, originario (...) in tempi in cui - tra l'ordine fascista e il disordine della ricostruzione - con l'eredità nazionale e italiana e popolare (quella delle "genti") si gioca tra offuscamento e dispersione». (In: Mario Soldati e il cinema, a cura di Emiliano Morreale, Donzelli Editore, Roma 2009).
È l'inizio di una nuova ondata salgariana: La vendetta dei Thugs (1952) di Gian Paolo Callegari; Il tesoro del Bengala (1953) di Gianni Vernuccio; I Misteri della Giungla Nera (1953) e La vendetta dei Thugs (1954) di Gian Paolo Callegari; Il figlio del Corsaro Rosso (1958) di nuovo di Primo Zeglio; Cartagine in fiamme (1959) di Carmine Gallone; oltre a due film di reminiscenza salgariana: Il corsaro della mezza luna (1957) di Giuseppe Maria Scotese e La scimitarra del saraceno (1959) di Piero Pierotti.
Tra questi registi, Gian Paolo Callegari nel 1946 aveva collaborato con Indro Montanelli e Vittorio Metz a Pian delle Stelle, soggetto sulla Resistenza Italiana commissionato dal Corpo Volontari della Libertà. Dunque tra questi realizzatori soltanto Carmine Gallone aveva un passato di cineasta di regime, e va comunque ricordato che nel dopoguerra si era spostato su posizioni liberali analoghe a quelle sopracitate, realizzando anche un film resistenziale come Davanti a lui tremava tutta Roma (1945) con Anna Magnani. Riguardo alla riscoperta del patrimonio ottocentesco, del resto, Gallone, in tutta la sua carriera, aveva testardamente insistito nella riproposizione cinematografica della grande tradizione del melodramma italiano, giungendo nel 1954 a una vera e propria summa: Casa Ricordi, uno splendido film di ricostruzione storica e neo-risorgimentale, che ebbe vasta risonanza negli Stati Uniti. Il film si conclude con queste parole-manifesto di Giulio Ricordi: «Quello che è stato fatto non conta più, conta solo e sempre quello che riusciremo a fare domani». In sostanza, in questo difficile dopoguerra, se è ancora lungi da venire e distante dalle intenzioni dei registi citati un salgarismo cinematografico "di sinistra", si ha quanto meno cura di ritrovare in Salgari una radice oltre che pre-fascista, a-fascista: l'avventura liberata dalla propaganda, terreno di libero gioco della fantasia e di ricostruzione di un legame tra intellettuali e popolo non imposto dall'alto, né sulla base di dettami di appartenenza politica e/o di classe, ma fondato su una tradizione, su delle radici profonde, e nuovamente espresso con un gusto, diremmo oggi, "trasversale", cui non è estraneo un intento pedagogico.
4. Il salgarismo commerciale degli anni Sessanta
Il decennio successivo è il vero boom del cinema salgariano. Escono uno dopo l'altro: Morgan il pirata (1960) di Primo Zeglio; Sandokan, La Tigre di Mompracem (1963), La Montagna di luce (1964), I Pirati della Malesia (1964) e I tre sergenti del Bengala (1964), tutti e quattro di Umberto Lenzi. Quest'ultimo lavoro, tratto da un romanzo dello stesso Lenzi, è un esplicito omaggio a Salgari. Per quanto si tratti di un film di recupero, costruito cioè con frammenti scartati da altri film, l'autore lo considera il migliore tra i suoi film salgariani. Umberto Lenzi si dichiara anarchico, di certo è sempre stato un autore di limite, insofferente di ogni disciplina accademica e alieno da ogni prudenza politically correct. Nel decennio successivo sarà capofila del filone poliziottesco di Merli, Milian e compagni, e negli '80 pioniere al contempo dello splatter antropofago e di un cinema bellico totalmente ridefinito, al di fuori di ogni etica patriottica. Nel salgarismo di Lenzi, la parte del leone la fa il muscolare Sandokan di Steve Reeves. È grazie a questo attore-culturista antesignano di Schwarzenegger che il cinema salgariano italiano riesce a ottenere qualche attenzione nel difficile mercato nordamericano. Lenzi non sottolinea più di tanto le caratteristiche anti-colonialiste del personaggio (del resto, l'epoca non lo consentiva ancora), ma riprende il mito dell'Eroe muscolare, di nuovo sul confine (ormai sottilissimo) tra il peplum mitologico e l'avventura esotica.
Altro regista salgariano di spicco in questi anni, è Luigi Capuano, che sforna La Tigre dei sette Mari (1962), Sandokan alla riscossa, Sandokan contro il Leopardo di Saravak, I Misteri della Giungla Nera (tutti e tre del 1964) e L'avventuriero della Tortuga (1965). Per il ruolo di Sandokan, Capuano sceglie gli attori americani Ray Danton e Guy Madison, scelta significativa del trasformismo di molto cinema italiano dell'epoca che tende a proporsi sul piano internazionale e nazionale sotto una veste all'americana che gli consenta di sfruttare un filone di buon successo.
Scrive su quegli anni Gian Piero Brunetta (in: Storia del cinema italiano - dal 1945 agli anni ottanta, Editori Riuniti, Roma 1982): «Nel periodo aureo del biennio 1966 e '67, raddoppiano i contratti di vendita di film (italiani) all'estero, fino a raggiungere la cifra ragguardevole di 4.295 titoli. Il 90 per cento di questi titoli approda nel Sud America e nei paesi del terzo mondo e solo una cifra modesta penetra nel mercato nord-americano. Anche in Francia il cinema italiano ottiene lusinghieri successi commerciali e consensi da parte dei pubblici popolari, mentre stenta molto a penetrare con i suoi titoli più prestigiosi. Se scorriamo i titoli delle centinaia di opere uscite a Parigi tra il 1964 e il 1965, ci accorgiamo che vi approdano, a getto continuo, film totalmente ignorati dalla critica italiana (...) titoli d'avventura e in larga parte mitologici e/o pepla». Segue un fitto elenco, in cui figurano tra gli altri: Io, Semiramide di Primo Zeglio, Il leone di San Marco di Luigi Capuano, e Il gladiatore di Messalina di Umberto Lenzi. Piratesco, peplum, avventura esotica si mescolano al salgarismo, in mille sfumature e a diversi livelli di citazione, dal riferimento esplicito, al richiamo indiretto. Una serie di titoli: La Venere dei Pirati (1960) di Mario Costa; I Pirati della Costa (1960) e Il terrore dei mari (1961) di Domenico Paolella; l'originale Le avventure di Mary Read (1961) di Umberto Lenzi che propone Lisa Gastoni nel ruolo della celebre (e storica) donna pirata; Il conquistatore di Maracaibo (1961) di Eugenio Martin; I moschettieri del mare (1961) di Steno; Gordon, il Pirata nero (1962) di Mario Costa; Il Dominatore dei Sette Mari (1962) di Primo Zeglio; due interessanti film di Mario Camerini in parte debitori di Salgari e in parte di Fritz Lang: Kalì Yug la dea della vendetta (1963) e Il Mistero del Tempio Indiano (1964); Il Corsaro Nero nell'Isola del Tesoro (1965) di Vertunnio de Angelis; Surcouf, l'eroe dei sette mari (1966) di Sergio Bergonzelli e infine un film salgariano tout court: I Predoni del Sahara (1966) di Guido Malatesta. Vanno aggiunti all'elenco i molti film di commistione tra peplum e piratesco e/o cappa e spada, tra i quali si possono citare: Robin Hood e i pirati (1961) di Giorgio Simonelli; Giulio Cesare contro i Pirati (1962) di Sergio Grieco; Sansone contro i pirati (1963) di Tanio Boccia; Sansone contro il Corsaro Nero (1963) ancora di Capuano, e, sempre nello stesso anno, Zorro contro Maciste di Umberto Lenzi. Fatale che una simile exploitation presti il fianco alla parodia. Purtroppo Totò contro il Pirata nero (1963) di Fernando Cerchio non si può dire un film riuscito. Popolarissima invece la serie di sceneggiati televisivi per bambini Giovanna la nonna del Corsaro Nero (1961) di Vittorio Metz, che ha ben due seguiti: Le nuove avventure di Giovanna la nonna del Corsaro Nero (1962) e Giovanna alla riscossa, più forte di un bicchiere di gin (1966). La serie, al di là dell’omaggio al Corsaro Nero, nasce sulla scia del successo dello sceneggiato televisivo del 1959 L'Isola del tesoro di Anton Giulio Majano. Negli anni '60, la RAI contribuì al più generale rifiorire del genere "cappa e spada" con altri due sceneggiati: Scaramouche (1965) cinque puntate di Daniele D'Anza con Domenico Modugno, versione musicale del romanzo di Rafael Sabatini, e La Freccia Nera (1969) tre puntate di Anton Giulio Majano, con Loretta Goggi, tratto dal romanzo di Stevenson.
5. Sandokan tra Ernesto Che Guevara e la televisione
Dopo la sbornia è sonno profondo. Gli anni '70 iniziano con il modesto Le tigri di Mompracem (1970) di Mario Sequi e Il corsaro nero (1971) di Lorenzo Gicca Palli (Vincent Thomas) con Terence Hill nel ruolo del protagonista (Il Capitano Blackie, che nulla ha a che vedere con il Signore di Ventimiglia) e Bud Spencer in un ruolo minore (Skull). Da citare il cortometraggio di Corrado Farina, Salgari della nostra infanzia (1971), che già dal titolo implica un’idea di Salgari come di un autore del passato, da evocare nostalgicamente, ma senza possibile futuro. Sul piano internazionale, il cinema piratesco in generale sembra defunto. Nella prima metà degli anni '70, i film sui pirati si contano sulla punta delle dita di una sola mano. Il mondo giovanile è profondamente cambiato. È ben vero che i ragazzi del Sessantotto, in Italia e in America Latina, si erano nutriti di Salgari fin da bambini, ma nel contesto delle lotte sociali e per i diritti civili di quella prima metà del decennio, il ricordo affettuoso per il romanzo popolare veniva coltivato in segreto. Ci si occupava di politica, ci si abbeverava di saggistica, si ascoltavano, peraltro piuttosto distrattamente, verdetti inappellabili sulla presunta Fine del Romanzo. Il vero linguaggio unificante di quella generazione era la musica pop-rock e folk, non la letteratura. Giunge dunque come un fulmine a ciel sereno il Sandokan televisivo in sei puntate (1976) di Sergio Sollima, in assoluta controtendenza rispetto alle precedenti versioni del Pirata della Malesia, ma non rispetto alla sensibilità di una generazione diffusamente anti-imperialista. Tullio Kezich, incaricato di seguire il progetto da Ettore Bernabei, racconta così la genesi della serie (in Franca Faldini e Goffredo Fofi, Il cinema italiano d'oggi 1970-1984 raccontato dai suoi protagonisti - Mondadori, Milano 1984): «Cominciò la mia peregrinazione tra i registi di buona firma, li interpellai tutti e devo dire che tutti rifiutarono Sandokan; un po' perché non erano disposti a fare il passo dal cinema alla televisione, un po' perché non volevano occuparsi di una cosa che li avrebbe tenuti un anno lontani da Roma. Finalmente avvicinai Sollima che accettò subito: mi parve quasi un miracolo. Con Sergio facemmo tutti i sopraluoghi in India e poi in Malesia, riscrivemmo completamente i copioni e trovammo Kabir Bedi». La scelta innovativa di girare non in studio, ma in scenari reali, unita a quella piuttosto rivoluzionaria, di un attore indiano come protagonista, spazza via d'un colpo il lato carnevalesco, da histoire en travesti, che accomunava i film di pirati ai pepla. Kezich ricorda il grande contributo offerto alla serie da «Vittorio Nino Novarese, che viveva a Hollywood dove aveva vinto tre Oscar. Nino era tra i più grandi esperti di storia del costume, ma anche un ottimo sceneggiatore. Amando molto le storie, sceneggiava con l'idea del disegno e disegnava con quella del racconto. In tutto lo sceneggiato c'è quasi una eco del modo di fare cinema degli anni Trenta, dei grandi film di Blasetti, che sono quelli in cui Novarese è stato art director e strettissimo collaboratore». Questa eco però risuona in un contesto completamente diverso. È come un nuovo inizio. I contenuti anti-colonialisti, seppure tenuti a freno dalla destinazione televisiva, agli occhi delle giovani generazioni risultano dominanti. Al mito di Sandokan si sovrappone fatalmente quello del "Che". Secondo Paco Taibo II (autore tra l'altro del romanzo-omaggio a Salgari Ritornano le tigri della Malesia (più antimperialiste che mai), Marco Tropea Editore, Milano 2011), Ernesto Che Guevara era un grande estimatore di Emilio Salgari di cui aveva letto una ventina di romanzi. La cosa non deve sorprendere, considerando la grande popolarità di Salgari in America Latina. Il poeta cubano Félix Píta Rodríguez (1909-1990), grande appassionato di Salgari, gli aveva dedicato una Ode (alla fine degli anni '40) nella quale citava a profusione Jolanda, Tremal Naik, Yanez, Sandokan, il Corsaro Verde, Rosso e Nero, osservando acutamente in due versi tanto rivelatori di una tradizione consolidata quanto anticipatori di un nuovo vissuto generazionale da vivere clandestinamente: «Pero Salgari estaba en el segreto, como los conspiradores». Rodriguez sceneggiò Il Corsaro Nero per la radio (medium con il quale iniziò a collaborare in Argentina e poi in diversi paesi dell'America Latina fino al ritorno a Cuba dopo la rivoluzione). In America Latina, dove era stato forte anche il mito di Giuseppe Garibaldi, una lettura anti-colonialista e libertaria di Salgari era pressocché inevitabile, né pareva una controindicazione notare che i personaggi di Salgari (sia il Corsaro Nero che Sandokan) combattono anche (e soprattutto) per motivi personali di vendetta e/o di solidarietà con gli amici. I due aspetti, quello politico e quello personale, non potevano essere disgiunti, derivando da Il Conte di Montecristo di Dumas, nel quale la rivalsa individuale, diciamo pure la vendetta, assume un indubbio significato sociale e politico. Anche se tutti questi elementi non erano del tutto trasparenti per il pubblico televisivo italiano, gli scenari della Malesia, in un periodo ancora pervaso dallo spirito di rivolta anti-imperialista sbocciato con le contestazioni contro la guerra al Vietnam, parlavano da soli. Sottratto alla favola esotica e piombato in uno stravagante realismo metaforico, il Sandokan di Sollima appare come il frutto maturo di quel Salgari clandestino che la generazione del '68 aveva coltivato in silenzio. Ma a questo nuovo impulso, d'origine sociale, se ne aggiungeva uno mediatico, di cui lo stesso Sollima tardò a rendersi conto. L'enorme successo della serie televisiva, lo spinse a realizzare per il cinema Il Corsaro Nero (1976) che ripresentando Kabir Bedi in un'improbabile interpretazione del Signore di Ventimiglia, capovolgeva gli assunti "realistici" della serie e ne dissolveva le metafore politiche. Ma ancor più spiazzante per lui, fu il modesto successo di botteghino del seguito della serie, uscito al cinema, prima che in televisione, cioè La tigre è ancora viva: Sandokan alla riscossa! (1977). Sergio Sollima ricorda che il pubblico, ormai aduso a considerare Sandokan come personaggio televisivo, quasi non si accorse dell'uscita del film nelle sale o comunque restò in attesa, per vederlo, che passasse (gratuitamente) in televisione. In sostanza, alla svolta sociale e di costume, si sovrapponeva in quegli anni una nuova realtà mediatica che annunciava già l'età della sudditanza del cinema alla TV. Si creava oltretutto una forbice per cui ciò che in televisione appariva come innovativo, in cinema risultava datato. Il Sandokan televisivo non contribuì affatto alla rinascita del salgarismo cinematografico, si può anzi dire che ne costituì il monumento funebre.
6. Dalle ultime repliche ai nuovi rimpianti di infanzia perduta
Gli unici film salgariani degni di nota degli anni '80, non furono italiani, bensì del Messicano Gabriel Retes che dedicò allo scrittore genovese la sua cospicua opera in due parti, del 1985: Los Naufragos del Liguria I e II: Los Piratas. L'anno successivo, il sontuoso Pirati di Roman Polanski, ebbe un esito commerciale sconfortante. Delle avventure piratesche non importava più niente a nessuno. In Italia, Alberto Negrin tentò senza grandi esiti di rinnovare il successo del Sandokan con una trasposizione televisiva de: Il segreto del Sahara (1987). Ci riprovarono Kevin Connor con i tre episodi de: I Misteri della Giungla Nera (1991) e Gianfranco Albano con le due puntate de: L'elefante bianco (1998). Troppo evidente la nostalgia per l'irripetibile Sandokan di Sollima, il quale dal canto suo, propose al cinema Il figlio di Sandokan (1998) con Kabir Bedi, senza lasciare traccia, come era del resto avvenuto in precedenza a Enzo G. Castellari con il suo: Il ritorno di Sandokan (1996) anch'esso interpretato da un Kabir Bedi ormai sul viale del tramonto. Castellari si era già dedicato al genere con Le avventure e gli amori di Scaramouche (1976) assai liberamente tratto da Sabatini. Il ritorno di Sandokan era una mini-serie televisiva (stavolta per Canale 5) più che dignitosa, ma poco rilevante, essendosi ormai dissolto il legame tra contestazione giovanile e salgarismo (che peraltro Castellari non era adattissimo a rispolverare).
Al 1991 risale la coproduzione internazionale (Italia, Spegna, Germania, Francia, Austria) I misteri della giungla nera, mini serie TV in tre episodi, di Kevin Connor, con Kabir Bedi, Stacy Keach e Virna Lisi, andata in onda su Rai Uno e replicata nel 1994 come film. Salgari viene riproposto per bambini con delle serie a cartoni animati come i nove episodi diffusi dalla rete britannica Channel 4 nel 1992 che ricreano Sandokan sotto l'aspetto di una tigre inturbantata, cui fa seguito il film animato Sandokan (1995) di Claudio Biern Boyd. Di Gianfranco Albano è la miniserie in due puntate L’elefante bianco (1998), con Remo Girone, Axelle Grelet, Vincent Lecoeur e Lino Capolicchio, definita dal critico televisivo del «Corriere della Sera» Aldo Grasso la «versione taoista di Salgari». Sempre nel 1998 Orlando Corradi produce il cartone animato Il Corsaro Nero, in ventisei episodi. Del 1999 è un’altra coproduzione italo spagnola, sempre di Corradi: i ventisei episodi del cartone animato Jolanda, la figlia del Corsaro Nero (ancora disponibile su RayPlay). Marco e Gi Pagot realizzano per la RAI (ma andranno in onda anche su Italia 1) i ventisei episodi di Sandokan la tigre della Malesia (1999) e gli altri ventisei di Sandokan, la tigre ruggisce ancora (2000) cui farà seguito nel 2004 una terza serie a cartoni animati, di eguale durata: Sandokan il coraggio della Tigre (2004). Del 2008 è Sandokan – Le due tigri, sempre in ventisei episodi, serie che mescola ai tradizionali ingredienti salgariani, magia e fantastico.
In questo clima di ritorno all'infanzia, non si può non citare il film di Steven Spielberg Hook (1991) con Dustin Hoffman nel ruolo di Capitan Uncino, ma pare un nostalgico, quanto effimero omaggio di una generazione di eterni Peter Pan.
Quando tutti ormai li danno per morti, i pirati cinematografici rinascono con il ciclo della Disney I Pirati dei Caraibi, che origina sicuramente dalle suggestioni spielberghiane. Il primo film del ciclo è del 2003: Pirati dei Caraibi - La maledizione della prima luna; cui fanno seguito Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma (2006); Pirati dei Caraibi - Ai confini del mondo (2007); Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare (2011); Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (2017). L'interpretazione pop di Johnny Depp conferma la sua cifra stilistica che non sta nell'aderire al racconto, ma nel farne spunto e pretesto per una esibizione narcisistica. Ha scritto in proposito Goffredo Fofi: «Con che fatica ci dà dentro Johnny Depp a imitare, guitteggiando disneyanamente, gli Errol Flynn e i Tyrone Power di ieri, e magari i Douglas Fairbanks del muto! Altre infanzie, altri modi di immaginare l'avventura, e un altro cinema, un'altra letteratura...» (in: Rileggendo Rafael Sabatini, «Hamelin» n.19, dicembre 2007). Nel suo insieme, questa serie di film rivitalizza il genere piratesco-infantile con qualche sfumatura horror. L'estetica di questo ciclo è così precisa e sottolineata, con squarci onirici pregevoli (come il mare mutato in bianco deserto, in un delirio febbrile del personaggio di Depp), sequenze iper-spettacolari da tecnologia avanzata, e budget produttivi stellari, da non poter rappresentare un modello per una produzione imitativa a catena, tantomeno da parte della nostra scassata industria cinematografica nazionale. In ogni caso, non c’è alcuna radice salgariana in questa serie.