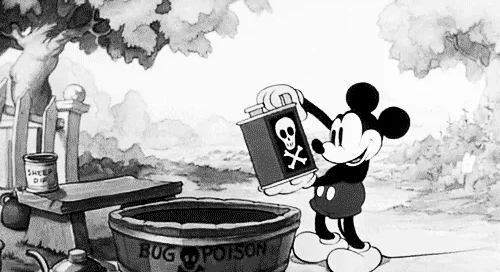BOILER #16
Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.
Ciao!
Cosa c’entra il Viaggio sulla Luna di Cyrano de Bergerac con la Storia della Musica? Lo spiego in un articolo inedito nella parte open di questo numero di Boiler. Cerco anche di rispondere a un altro interrogativo: Cyrano può essere considerato uno dei padri della fantascienza o quantomeno della narrativa di anticipazione? In questo caso la risposta è nel testo stesso del suo romanzo che contiene un’invenzione davvero sorprendente.
Nella parte su abbonamento, continua la Biblioteca dei bestseller dimenticati 2- I primi saranno gli ultimi con una disamina di That Pretty Young Girl (1889) stravagante sensational novel della scrittrice americana Laura Jean Libbey, autrice di popolarissimi romanzi rosa del genere Working Girls and Millionaires. Questo fa eccezione, perché è un intrigo giallo talmente intricato che fatica a sbrogliarlo persino l’autrice.
Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.
I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.
Buona lettura!
Gianfranco
CYRANO SULLA LUNA
di Gianfranco Manfredi
Non era certo un dissoluto l’abate Pierre Gassendi (1592–1655), considerato tra le figure più eminenti del libertinismo, corrispondente di Galileo e avversario di Descartes, studioso dei corpi celesti, delle comete, delle eclissi lunari e delle macchie solari; a lui si deve la definizione di “aurora boreale”. I suoi discepoli lo chiamavano Santo Padre. In una biografia anonima pubblicata a Venezia nel 1825, si legge:
Costumi ebbe dolci, semplici, anco festevoli con gli uomini, era fermo e confidenziale nel commercio; le sue maniere spiravano amenità; la sua modestia cresceva diletto a conversare con esso.
Non disdegnava le taverne e gli stravizi, invece, uno dei più brillanti allievi di Gassendi: Savinien de Cyrano de Bergerac (1619-1655), di origini borghesi, ex militare, formidabile spadaccino, finissimo letterato, noto per la sua vita licenziosa. La sua biografia compare nel libro di Frédéric Lachèvre Les Oeuvres Libertines (Champion, Parigi, 1921). Vi si legge che Savinien aveva cominciato a frequentare i locali parigini a diciassette anni:
Presto lo si contò tra i crapuloni e i forti bevitori dei migliori cabarets, tra scherzi di dubbio gusto e libagioni assidue e prolungate oltre misura. (…) Prese anche il pessimo vizio del gioco.
Dato che suo padre resisteva fermamente alle sue continue richieste di quattrini, a Savinien, senza più un soldo, non restò altra scelta che arruolarsi volontario. Non furono però le battaglie a condurlo a una morte precoce (a 36 anni) ma la sifilide, che contrasse nel 1645. D’altro canto, fu proprio la malattia ad allontanarlo dagli stravizi, a vantaggio dello studio e della scrittura. Una delle sue opere più originali apparve postuma, nel 1657, con il titolo Histoire Comique. L’autre monde ou Les états et empires de la lune. Seguì Les états et empires du soleil, pubblicato nel 1662. All’epoca queste sue opere fantastiche e satiriche si fecero notare, ma senza diventare celebri. Trovarono adeguata attenzione soltanto dopo che la fama di Cyrano venne rinverdita e dilatata dalla commedia di Rostand (1897).
Cyrano sicuramente aveva presente il viaggio di Astolfo sulla luna del canto XXXIV dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, ma c’è di più. Mentre ancora stava scrivendo il suo viaggio sulla luna, si era imbattuto in un romanzo, tradotto dall’inglese, dall’identico argomento: Francis Godwin L’Homme dans la Lune ou le voyage chimérique fait au Monde de la Lune, nouvellement découvert par Dominique Gonzales, Adventurier Espagnol autrement dit Le Courrier volant (Piot-Guignard, Parigi, 1648). Godwin era un vescovo inglese, prozio di Jonathan Swift, che si ispirò a questo romanzo per I viaggi di Gulliver (1726). Pare che Cyrano, tenendo molto alla propria originalità, fosse rimasto urtato sulle prime dall’uscita (postuma) del romanzo. Poi però ne accolse alcuni spunti, offrendone varianti molto personali. Astolfo aveva spiccato il volo su un carro trainato da cavalli di fuoco, partendo dal Paradiso terrestre; il Gonzales di Godwin si era involato su una macchina volante trainata da grandi oche, partendo delle Tenerife; Cyrano decolla grazie a una geniale cintura di ampolle aerostatiche riempite di rugiada e si prende cura di precisare: «i miei occhi non riconobbero in tutto l’emisfero una sola traccia del Paradiso terrestre».
Mi concentrerò su un momento esemplare dei suoi incontri con i giganteschi abitanti della luna. Alle disparità di classe, sul satellite, corrispondono due diversi idiomi: uno per i grandi e uno per il popolo. Traduco dall’originale:
Quello dei grandi non è altro che una differenza di toni inarticolati, pressappoco somiglianti alla nostra musica, quando non si sono aggiunte le parole alla melodia, ed è certo un’invenzione al contempo utilissima e piacevolissima: perché, quando sono stanchi di parlare, o quando disdegnano di prostituire la loro gola a quest’uso, prendono un liuto, o un altro strumento, di cui si servono per comunicare il proprio pensiero altrettanto bene che con la voce; così che quando si incontrano in gruppi fino a quindici o venti persone, per discutere di una questione teologica, o un problema legale, lo fanno in concerto, il più armonioso che posa solleticare l’orecchio. Il secondo, in uso fra il popolo, si esegue dimenando le membra, tuttavia non come si potrebbe immaginare, perché certe parti del corpo esprimono un intero discorso. Per esempio, agitare un dito, una mano, un orecchio, un labbro, un braccio, un occhio, una guancia, fa di ogni singolo gesto un’orazione o un periodo interi. Altre movenze designano parole, come un aggrottar di fronte, diverse contrazioni muscolari, rovesciamenti di mani, battito di piedi, contorcimenti delle braccia; così, quando parlano, avendo per costume di circolare nudi, lo spettacolo delle loro membra, aduse a gesticolare concetti, non dà l’idea di gente che stia parlando, ma di corpi che tremano.
Essendo, per Cyrano, la Luna una proiezione fantastica della Terra, è facile intendere la sua metafora: potenti e umili parlano due lingue diverse, una sublimata in musica, l’altra gestuale, corporea, fino al limite del convulsionismo. Riguardo ai grandi, la stessa musicalità che adoperano nel linguaggio la applicano ai libri. Sorprendentemente, Cyrano evoca gli audiobook e una forma primitiva di grammofono. I libri lunari, invece che in rilegature, sono contenuti in scrigni che quando vengono aperti rivelano un ingranaggio metallico simile a quello degli orologi.
È davvero un Libro; ma un Libro miracoloso, senza fogli e senza caratteri di stampa; insomma, un Libro che rende inutili gli occhi; non servono, per fruirne, altro che le orecchie. Quando dunque a qualcuno va di leggere, carica a molla, con un gran numero di piccole nervature d’ogni genere, questa macchina; poi, sposta l’ago sul capitolo che desidera ascoltare, e subito ne scaturiscono, come dalla bocca di un uomo o da uno strumento musicale, tutti i distinti e differenti suoni che servono tra i grandi Lunarî, all’espressione del linguaggio. Dopo aver riflettuto su questa miracolosa invenzione nel fare dei Libri, non mi sorprende più notare che i giovani di codesto paese possiedano più conoscenza a sedici, diciotto anni, che le barbe grigie del nostro paese; perché sapendo leggere alla stessa stregua che parlare, non restano mai senza lettura; in camera, passeggiando, in città, in viaggio, possono tenersi in tasca o appesi alla cintura una trentina di questi Libri e non devono fare altro che girare una molla per udirne un unico capitolo o molti di più, se sono dell’umore di ascoltare un Libro per intero: così avete eternamente intorno a voi tutti i Grandi Uomini, morti e viventi, che vi intrattengono a viva voce.
Si può considerare senza dubbio anticipatorio questo brano, ma collocandolo nel suo tempo, è indubbio che si riferisca al ruolo preminente che stava assumendo la musica. Nel secolo successivo, in Francia, esploderà un furente conflitto Melodia versus Armonia. Non entrerò qui nei dettagli di questo dibattito, che non può che apparire stravagante agli occhi dei musicologi contemporanei, basti sottolineare che i sostenitori della melodia, tra i quali Rousseau, nel rimarcarne la centralità, non solo davano primato al canto, ma a un linguaggio espresso in parole, cioè a un discorso tanto espressivo, quanto coerente, e indicativo di culture nazionali (seppur percepite non in termini di Stato-Nazione, ma territoriali: le popolazioni di un certo territorio), mentre i sostenitori dell’armonia che andava raffinando gli accorgimenti tecnici e gli arrangiamenti, esasperando la polifonia, rovesciavano il rapporto tra il canto e gli strumenti facendo del primo una sorta di complemento, una voce-strumento usata più come suono, anche virtuosisticamente, che per il contenuto espresso nei versi. Messa così, la questione, per quanto bizzarra sul piano strettamente musicale, interpreta però una scissione percettiva e una differenza del gusto che resterà permanente: nell’Ottocento comporterà un’aperta rivalità tra musica operistica e sinfonica, e oggi continua a manifestarsi, per esempio, nelle accese contese tra coloro che sostengono l’egemonia del testo sulla musica, e coloro che sostengono il contrario. Persino nel campo della canzone, gli irriducibili del primato del testo valutano l’eccellenza di un cantautore sulla base del lato poetico della composizione, cioè sulle parole, nel quasi assoluto disdegno per la qualità musicale che può essere anche corriva; mentre gli esteti dell’armonia e del ritmo, tollerano senza problemi un testo poeticamente scadente, o addirittura ridotto a puri fonemi. I due partiti, ieri come oggi, lasciano sconcertati tutti coloro che pretenderebbero pari livello nel testo e nella musica, ma tant’è. Tornando a Cyrano, egli pare segnalare un passaggio tra un dibattito intellettuale fondato su un sapere scritto e retorico, che conduce a conflitti, e una ricerca di sonorità pura, che tende di per sé ad armonizzare i singoli in un ensemble concorde, e in virtù della quale la formazione culturale va a coincidere con l’ascolto, più che con la lettura.
Il racconto fantastico, in Cyrano, si incentra sulle conseguenze estreme di tendenze in atto, qui sulla Terra, non sulla Luna. Ma questa declinazione del fantastico già lo orienta verso la narrativa di anticipazione. Non si narrano mondi fantastici nei quali tutto è possibile e differenti modelli di esistenza danno luoghi a regni separati e alternativi, bensì un mondo possibile, non astrattamente ipotetico, che conduce alle estreme conseguenze dinamiche già in atto.