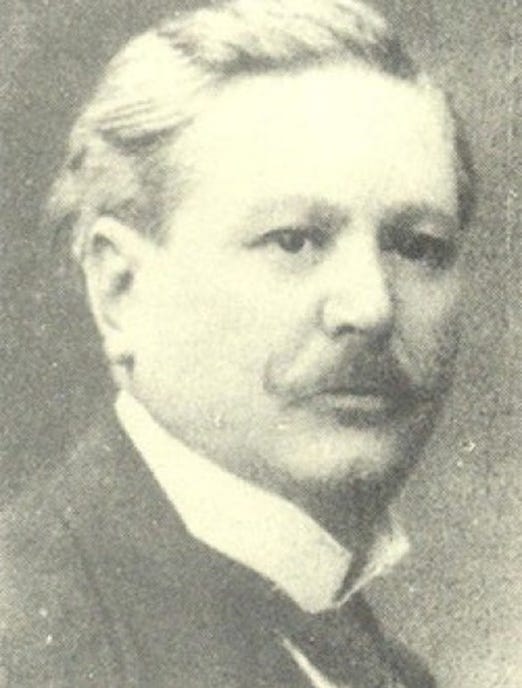BOILER #9
Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.
Essendo risultate gradite le POESIE CICLISTICHE MILANESI DELLA FINE OTTOCENTO pubblicate sul numero scorso, eccovi stavolta, nella parte open, un altro testo risalente alla fine ottocento e intitolato CICLISMO E SOCIALISMO, cronaca di una scampagnata fuori porta e dell’incontro di un gruppo di giovani ciclisti con una famiglia contadina, preceduto da una mia breve introduzione.
Nella parte su abbonamento, La Biblioteca dei bestseller dimenticati si concentra stavolta su Mary Elizabeth Braddon e il suo romanzo Lady Audley’s Secret (1862), ispirato a una vicenda criminale autentica che aveva suscitato appassionate controversie. Devo avvisare che stavolta l’esame del testo e gli approfondimenti sulla scrittrice coprono uno spazio più lungo del solito. Molte, infatti, sono le questioni coinvolte: la genesi della narrativa “gialla”, l’intreccio strettissimo con la cronaca criminale e scandalistica, il confronto tra femminismo e misoginia, il ruolo della follia nel delitto, l’uso letterario del monologo interiore, la vicinanza e la presa di distanza di Braddon dai maggiori letterati francesi suoi contemporanei. Non siamo di fronte a un romanzo di puro intrattenimento “sensazionalistico”, ma di fronte a un’opera cruciale degna di essere riscoperta non tanto per lo stile o per il giusto (inesorabilmente invecchiati), ma per la vastità delle problematiche presentate e la varietà delle soluzioni narrative offerte.
Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.
I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.
Buona lettura!
Gianfranco
CICLISMO E SOCIALISMO
di Gianfranco Manfredi
(«ZonaLetteraria», Sport e controllo sociale, maggio 2019)
Nel 1895 il giornalista Pierre Giffard scrisse: «Il velocipedismo non è uno sport, ma un fattore di benessere per la nostra civiltà». Giffard, direttore di giornali ciclistici e grande organizzatore di corse, nel 1891 aveva pubblicato una storiella intitolata La Regina Bicicletta, con in copertina una giovane ragazza che inalberava una bicicletta sul capo come per coronarsene. Già questo era piuttosto significativo. Uno dei più importanti fattori di “civilizzazione sociale” apportato dalla bicicletta fu la maggiore libertà di movimento consentita alle donne e il diritto, ai tempi tutt’altro che scontato, di poter passeggiare in città da sole. Nel 1899 Giffard in un altro suo scritto (La Fine del cavallo) non soltanto proclamava il tramonto dell’aristocrazia equestre a vantaggio di un mezzo di trasporto più popolare, ma annunciava anche il prevedibile tramonto della bicicletta stessa a vantaggio dell’automobile. Di scenari futuri se ne intendeva: nel suo romanzo tascabile La Guerra Infernale (1908) profetizzò addirittura la Seconda Guerra Mondiale, mettendo in scena un attacco tedesco alla Gran Bretagna e la guerra tra Stati Uniti e Giappone. Mi è parso utile citare questi scritti, per sottolineare come i giornalisti che si occupavano di ciclismo fossero all’epoca non soltanto degli specialisti sportivi, ma degli analisti dei cambiamenti in atto, cambiamenti anzitutto sociali, nei quali la bicicletta ricopriva un ruolo fondamentale.
Certo le corse, le gare, i record sportivi, avevano un fascino che faceva da traino alla diffusione sociale della bicicletta; certo anche che le prime corse non erano esenti dai problemi che avrebbero segnato in forme diverse la storia futura del ciclismo, per esempio le scorrettezze in corsa e la scarsa affidabilità delle giurie. Nel 1895 i ciclisti Buni e Airaldi, dopo la corsa Bologna-Milano, presentano un reclamo contro il vincitore Costa accusandolo d’aver lasciato il gruppo per prendere il treno per un lungo tratto di percorso. Ci sono testimonianze che lo confermano: è stato notato alla stazione. Dal canto suo Costa si difende sostenendo che non era stato visto prendere il comando della corsa, perché il gruppo di testa si era fermato a mangiare in un’osteria dalla quale non si scorgeva la strada. La Giuria, per mettere a tacere lo scandalo, preferisce assolvere Costa. Questo caso fa sorridere, ma segna comunque il passaggio dal ciclismo sportivo vissuto in serenità amicale, a un ciclismo agonistico in cui pur di vincere non si arretra di fronte a comportamenti antisportivi. Nemmeno si può dire che il primo ciclismo fosse esente da fenomeni di tifo oltranzista fino al teppismo. Il 10 dicembre 1894 al velodromo d’inverno di Parigi scoppiano incidenti gravissimi: il pubblico scende in pista a saccheggiare trofei e il palco della Giuria viene dato alle fiamme.
Ma torniamo alla citazione iniziale. Com’è possibile che il direttore di un giornale sportivo sostenesse: «Il ciclismo non è uno sport»? Va letto come «il ciclismo non è soltanto uno sport, non è riducibile a questo». Il riferimento di Giffard al “benessere” è anzitutto di tipo salutistico. Molti infatti sostenevano che pedalare facesse male alla salute e sottoponesse le persone a sforzi eccessivi. L’idea del movimento come fattore di salute era ancora lontana all’essere accolta dall’opinione pubblica. Il riferimento alla “civiltà” va oltre. Anzitutto va inteso nel senso proprio della “città”, perché fu nelle città, non nelle campagne, che alle origini si sviluppò il ciclismo. I vecchi velocipedi con la ruotona, erano un mezzo di trasporto aristocratico. Si diceva dei nobili «sono scesi da cavallo per salire sul velocipede». In genere si limitavano a un giro intorno al loro palazzo, tanto per stupire il volgo. Ma la bicicletta, decisamente più comoda, veloce ed economica, cambiò la vita di tutti: anche della classe operaia che fino ad allora doveva raggiungere a piedi le grandi fabbriche dislocate in periferia. Diventò anche il mezzo di trasporto favorito degli studenti (da Milano all’Università di Pavia si andava in bicicletta). E infine favorì una nuova mescolanza tra le classi sociali.
Sul n.15 del 10 ottobre 1985 del settimanale milanese Il Ciclista (diretto dall’avvocato anarchico Eliso Rivera, poi fondatore e direttore della Gazzetta dello sport) si legge: «Chi avrebbe mai pensato di vedere in questa fine di secolo, il medico, il professore, il borghese in stretto colloquio col sarto, col falegname, col macellaio, per combinare una gita da compiere in allegra compagnia alla domenica prossima?». La gita era ovviamente fuori porta. I milanesi potevano esplorare i dintorni senza ricorrere alla carrozza e rendersi direttamente conto delle condizioni di vita dei contadini. Le allegre scampagnate consentivano di accostarsi a una realtà ben poco allegra. Nello numero in un articolo a firma Nino intitolato: Ciclismo e Socialismo, si narra una di queste gite, che ripropongo qui, senza ulteriori commenti.
* * *
Tutti montano in sella, l’allegra comitiva si muove, si grida, si parla, si saluta, si suonano i campanelli ed in pochi istanti si esce dalla città e si fugge con una velocità di 20 km all’ora, sollevando nuvole di polvere. Un paese segue l’altro, il più pratico della strada calcola la distanza che ancora ci divide da casa; chi scherza, chi ride, chi ricorda la bella accoglienza dei colleghi velocipedisti che abbiamo trovato alla città meta della nostra gita; insomma tutto spira gioia, allegria e pace. Tutto ad un tratto densi nuvoloni, che si addensano sul nostro capo, ci avvertono che la gita sta per essere turbata dalla pioggia che non è lontana. I pareri sono disparati: chi vuol fermarsi al primo paese, chi vuol continuare fino a casa, chi propone di tornare indietro per recarsi all’ultima tappa fatta per attendere il treno. Intanto grossi goccioloni cominciano a cadere, l’idea di continuare prevale, avanti, avanti, il terreno incomincia a diventare bagnato, la polvere si cambia in fango, le nostre maglie sono coperte di spruzzi di ruota, ma per questo non ci fermiamo. Finalmente la strada diventa assolutamente impraticabile, le pneumatiche minacciano di scivolare su quel piano bagnato, alcune bestemmie contro coloro che vollero continuare la strada, la pioggia cade a rovescio, i lampi ci guizzano sul capo; bisogna fuggire, ritirarsi. E dove? Non una casa, non un ricovero. Si prendono le macchine per mano e bestemmiando contro il dio Pluvio si continua la strada. Allo svolto della via appare un’umile casetta, mezzo diroccata, mezzo distrutta dal tempo; pare che silenziosa e rassegnata attenda lo sfogo della natura. Corriamo ad essa. Un uomo ed una donna ci accolgono con volto sereno, ci offrono ricovero, mentre alcuni bambini osservano con tanto d’occhi le nostre macchine infangate ed in uno stato veramente deplorevole. La pioggia che prima cadeva a grossi goccioloni ora si è cambiata in una di quelle pioggerelle noiose che talvolta durano giornate o anche settimane intere. La notte è calata in tutta la tristezza della sua oscurità, e quando apriamo l’imposta sgangherata della finestra non udiamo che i colpi continuati delle goccioline di pioggia che pare quasi ci schernisca e goda, tiranna, di averci sequestrati in quel tugurio. Intanto alcuno di noi pensa a rivolgere qualche domanda a quei poveri contadini che in un canto ci osservano senza osare di parlarci, impensieriti del caso nostro e quasi instupiditi di ciò che si vedono davanti agli occhi. Avete qualcosa da darci per questa sera? Chiede il più calmo dei nostri. Io li vidi arrossire; il marito spinse il coperchio della tavola, trasse due grossi pani e ce li porse dicendo che contavano dieci giorni di vita, e subito ce lo dimostrò battendoli sulla tavola e facendone uscire un rumore cupo come di un grosso sasso che cada sopra un piano di legno. La donna trasse una scodella di latte che ci disse essere già alquanto inacidito e: Questa è la nostra cena, ci disse: non abbiamo altro da offrire a lor signori. Gli allegri ciclisti di quella comitiva diventarono ad un tratto seri; non era la preoccupazione di dover passare la notte intera con un solo pezzo di pane raffermo di riso, era l’eloquenza di quelle risposte che ci aveva commosso il cuore. Quello era il loro cibo quotidiano! Rifiutammo e passammo la notte in quella cameretta a stomaco vuoto, cercando di dimenticare la fame che ci rodeva e pensando alla cena abbondante che ci attendeva a casa e al nostro soffice letto che rimaneva vedovo per tutta la notte. E quando al mattino, partiti da quella casetta ospitale dopo aver ricompensato quella povera gente che commossa ci ringraziava e diceva che si trovava umiliata di non averci potuto offrire nulla di conforto, spingendo regolarmente i pedali della mia macchina che cigolava per l’acqua presa il giorno prima, col capo abbassato sul manubrio pensavo a quelle vittime umane che vivono la vita quasi per adempiere a un dovere che fu loro imposto, quasi per scontare una pena a loro inflitta senza aver commesso alcun fallo. Chi mi aveva condotto a quel luogo di dolore? Chi mi aveva detto: osserva la miseria del tuo simile, impara ad amarlo e aiutarlo? Quella macchina luccicante, quell’oggetto freddo, silenzioso, privo di vita se non unito a me, il bicicletto che tante volte mi aveva condotto ai divertimenti, alle feste, che mi aveva lanciato tante volte in preda alla più pazza gioia. Ciclismo e socialismo. Due parole che rimano insieme; non vi pare che vadano abbastanza d’accordo anche nel loro svolgimento?