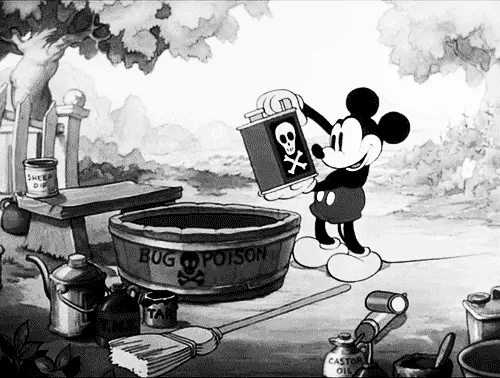BOILER #18
Ciò che bolle in pentola, ovvero… news, note, interventi, segnalazioni, anticipazioni, articoli, canzoni, podcast, video, saggi inediti… di tutto e di più.
Ciao!
In questo numero di Boiler, nella parte open, un mini saggio sullo scrittore primo premio Nobel americano Sinclair Lewis e in particolare su due suoi romanzi: Main Street, ambientato in una piccola città di provincia, e It Can’t Happen Here, romanzo distopico che immagina un’America fascista. Questi romanzi a confronto possono chiarire sia le lontane origini del populismo trumpiano che abbiamo imparato a conoscere, sia ad approfondire anche l’ideologia liberal, spesso fraintesa in Europa perché mescolata e confusa con orientamenti genericamente “di sinistra” ma non esattamente corrispondenti.
Nella parte su abbonamento, continua la Biblioteca dei bestseller dimenticati 2- I primi saranno gli ultimi con una disamina di George du Maurier, Trilby (1894), romanzo capostipite della celebrazione di Parigi come capitale dell’amore, ma con connotati inquietanti. Du Maurier era il padre di Dafne du Maurier di cui Alfred Hitchcock ha portato sullo schermo i racconti Rebecca la prima moglie e Gli uccelli.
Vi consiglio di leggere BOILER nel vostro browser perché, per via della lunghezza, l’email potrebbe venire tagliata.
I numeri precedenti di BOILER sono sempre disponibili per gli abbonati QUI.
Buona lettura!
Gianfranco
Sinclair Lewis e la coscienza Liberal
Introducendo il suo capolavoro Main Street, Sinclair Lewis scrive:
Questa è l’America - una città di poche migliaia di abitanti, in una regione di grano e mais e caseifici e boschetti. Nella nostra storia, la città si chiama “Gopher Prairie, Minnesota”. Ma questa Main Street è il prolungamento di tutte le Main Street sparse ovunque. La storia sarebbe la stessa in Ohio, Montana, Kansas o Kentucky o Illinois, e non sarebbe molto differente se raccontata nell’Up York State o sulle colline della Carolina. Main Street è il massimo della civilizzazione1.
Quest’ultima notazione va letta ironicamente. L’ironia è il registro letterario di Sinclair Lewis, in tutte le sue sfumature. L’incipit del romanzo, specifica ancor più chiaramente l’impostazione programmatica del racconto:
Su una collina lungo il Mississippi, dove due generazioni fa si accampavano i Chippewas, una ragazza si stagliava contro l’azzurro sbiadito del cielo del nord. Ormai non scorgeva più Indiani: vedeva mulini e le finestre scintillanti dei grattacieli di Minneapolis e St.Paul. Né stava pensando alle squaw, alle canoe, e ai trafficanti di pellicce yankee le cui ombre l’attorniavano. Stava meditando sul cioccolato fondente, sulle pièce teatrali di Brieux, sul perché le ruote girassero, e sul fatto che l’insegnante di chimica avesse notato la nuova acconciatura che le copriva le orecchie.
In poche righe Lewis traccia il cammino della civilizzazione, a partire dai Nativi Americani e dai primi, ormai invisibili, colonizzatori commerciali, fino al piccolo consumismo disponibile (la cioccolata al burro di noci), la drammaturgia didascalica a sfondo sociale di Eugène Brieux, autore francese che metteva in scena i patimenti delle giovani figlie dei lavoratori, l’ipocrisia modaiola delle associazioni caritatevoli, l’iniquità delle leggi ereditarie nei confronti delle donne. E infine i segreti della meccanica e della chimica uniti alla diffidenza degli educatori per certe nuove pettinature alla maschietta. Il monologo interiore, narrato dall’esterno, è un caleidoscopio di pensieri fuggevoli e sovrapposti, ciascuno inconcluso, tutti insieme significanti. Carol Milford, la protagonista di Lewis, richiama la Caroline “Carrie” Meeber di Dreiser, ma ne è al contempo l’esatto contrario. È orfana, ma figlia di un giudice. Ha necessità di lavorare, ma è già una ragazza emancipata, ben integrata nella grande città in cui studia al college, e con notevole profitto. La protagonista di Lewis ha in comune con quella di Dreiser l’aspirazione a realizzarsi, ed è questo che la rende insieme esemplare e simbolica.
Una ragazza in cima a una collina; ingenua, plastica, giovane; assetata d’aria come di vita. L’eterna, struggente commedia della gioventù piena di aspettative.
Tuttavia Carol non deve come Carrie inventarsi un futuro imparando a conoscere gradatamente i propri talenti, perché ne ha sin troppi: si interessa di sociologia e d’arte, gioca a tennis e a pallacanestro, è dotata di una bella voce, di un indubbio talento al pianoforte, suona anche il violino, recita, scrive, organizza, sempre un po’ delusa dai risultati, ma sempre di nuovo effervescente. Vitale, dinamica, nutrita di candide illusioni, Carol può scegliersi il futuro. Il problema per lei è la varietà delle opzioni che ha di fronte. Trova costrittivo il ruolo di casalinga, non ambisce a quello di insegnante. Il suo primo impiego è come bibliotecaria, ma sogna qualcosa di più e di davvero inedito: affermarsi come urbanista. Ha in mente un modello di piccola città più a contatto con la natura, più fraterna e solidale, più armonica architettonicamente, più verde e inserita nel paesaggio, moderna, ma non impersonale, insomma un modello di civilizzazione mite, venato di aspirazioni socialiste e comunitarie. Ha occasione di realizzare il suo sogno grazie all’incontro con il dottor Kennicott, un medico di una dozzina d’anni più vecchio di lei, sinceramente innamorato, che di Carol non apprezza soltanto la venustà e la giovinezza, ma anche le qualità intellettuali e la volontà di rendersi socialmente utile, mettendo in pratica ciò che ha imparato al college. Le propone di accompagnarlo, come sua sposa, a Gopher Prairie, cittadina rurale di circa tremila abitanti, per applicare lì i suoi ancora vaghi progetti di riqualificazione urbanistica. Carol compie così il cammino inverso a quello di Carrie, trasferendosi dalla grande metropoli (Carol ha conosciuto anche Chicago, dove ha frequentato i circoli intellettuali e bohémien) a una piccola città di provincia.
L’impatto, per lei, è al principio urtante. Gopher Prairie è ben lontana dalla sua vagheggiata piccola città. Sulla Main Street la modernità è rappresentata da un cinemino dove si proiettano le comiche di Fatty. L’edificio più imponente è quello della banca. Per il resto, botteghe maltenute e poco fornite, rivendite di giornali dove spiccano le pubblicazioni sconce, saloon in eccesso affollati di immigrati tedeschi e scandinavi che intonano canzoni altrettanto sconce mentre le mogli li attendono fuori, a cassetta dei loro calessini, per riportarli a casa ubriachi. Molte insegne di circoli massonici, ma il ceto dirigente è composto da negozianti semi illetterati appassionati di automobili (rare in città), per il resto conservatori a dir poco, tolleranti dei democratici più per convenzione che per convinzione (di elettori democratici ce n’è soltanto uno in città), fermamente antisocialisti, avversi a ogni genere di organizzazione sindacale e cooperativistica, sprezzanti nei confronti delle suffragette. Sono cortesi con Carol e ne tollerano le idee moderne e gli intenti sociali, ma soltanto perché è graziosa, perché proviene da una grande città, e perché è la moglie del medico locale che tutti giudicano un gran brav’uomo. Le loro mogli hanno come principale argomento di conversazione le malattie o le sfortune di questo o di quello. Non sembrano particolarmente infastidite dal fatto che i mariti lesinino loro i soldi anche per la normale spesa quotidiana, lo sopportano con rassegnazione, in passiva sudditanza al predominio del maschio padrone. Il massimo della civilizzazione, a Gopher Prairie (la prateria delle marmotte), è dunque rappresentato da una desolante Main Street persa in mezzo a una campagna semi incolta, dove i rapporti e i costumi sociali sono altrettanto selvatici.
Segue una fase di acclimatamento, durante la quale Carol scopre che è confortevole vivere in una piccola città dove tutti si conoscono, e la salutano e le sorridono, e nelle botteghe le danno il benvenuto e la chiamano signora Kennicott, e con qualche singola persona (una domestica simpatica, un’insegnante combattiva, un avvocato colto e riservato, un tuttofare svedese fieramente anarco-individualista) può intrattenere rapporti più complici, e tutto sembra più semplice che in una grande città. L’aria è buona, si può fare esercizio fisico, lunghe passeggiate, escursioni nella natura. Carol segue persino il marito a caccia. Ha sempre trovato inconcepibile nuocere a un uccellino, ma ora deve ammettere che c’è un’indubbia maestria virile nell’abbattere qualche grosso esemplare in volo, e anche a lei è concesso sparare, al punto che al primo centro si sente come una sorta di Annie Oakley. Carol si applica a rendere più confortevole la sua abitazione, ristrutturandola per ricavarne ambienti più ampi e ariosi, cambiando mobilia e tappezzeria, organizzando un ricevimento in costume (alla cinese), animando giochi di società, rendendosi protagonista ammirata e centro della curiosità pubblica, subito ammessa senza riserve dal club femminile.
A questa prima, calorosa accoglienza, subentra però il fastidio di essere continuamente osservata e giudicata, le piccole invidie, i pettegolezzi malevoli, e l’irritazione per il classismo di uomini e donne del ceto medio, per i quali il pregiudizio è inveterato e a doppio taglio: tanto per le domestiche mal pagate e sfruttate, i lavoratori, i poveri, i contadini e gli immigrati meno integrati, quanto per chi, come lei, sfoggia abiti eleganti, si rifornisce preferibilmente fuori città, sembra ostentare attitudini e ambizioni borghesi, pretese intellettuali, e voler spiccare a ogni costo, introdurre novità estranee, frequentando assai poco la chiesa, disinteressandosi alle chiacchiere imbalsamate del circolo femminile, preparandosi a diventare madre, ma senza soverchio entusiasmo. Carol resiste, ma comincia a pensare che quella piccola città sia renitente a ogni tipo di riforma, prigioniera di una mentalità retriva, contro la quale nulla si può fare. Non è preferibile allora l’anonimato della città della folla, non c’è forse maggiore libertà individuale in quell’indifferenza metropolitana che non si cura di nessuno e dunque non giudica nessuno?
Lewis qui ci offre il ritratto di una provincia non solo americana, la provincia universale, caratterizzata dalla ristrettezza mentale, e nella quale l’appartenenza comunitaria si manifesta come ostilità verso i diversi, gli individui non conformi, considerati come stranieri in casa, potenzialmente nocivi e dunque da tenere al guinzaglio. Eppure Lewis non trae da questa condizione di fatto lo spunto per esplorare crisi identitarie, per riflessioni filosofiche sull’essere e l’apparire, sull’ipocrisia delle convenzioni, insomma per inscenare drammi alla Pirandello. La sua è una rassegna di uno stato delle cose, cui il singolo può reagire senza piegarsi, comportandosi orgogliosamente a modo suo. Carol neppure per un istante medita di diventare come gli altri la vorrebbero, semplicemente si chiede se non sia stata lei a sbagliare nel trasferirsi a Gopher Prairie, a sposare un brav’uomo, persino eroico nel suo lavoro di medico di campagna che si prende cura con qualsiasi tempo e a qualsiasi ora di contadini poveri che spiccicano un inglese imparaticcio mescolandolo ai loro accenti scandinavi, eppure inerte nell’accettazione di un ambiente costrittivo, di un assetto sociale ingiusto e discriminatorio, in cui sembra rinvenire chissà quale aspetto positivo.
I progetti culturali e urbanistici di Carol si arenano: il circolo femminile incentra i suoi interessi sulla Bibbia o sulla nuova moda dei mobili alla cinese, e quand’anche si apre a un ciclo di letture di poeti inglesi, premia l’ovvio e preferisce non allargare l’orizzonte alla grande letteratura contemporanea. Il rinascimento urbano studiato con cura da Carol non viene supportato né da Luke Dawson, il milionario locale che non ha la minima intenzione di investire in città e medita di andarsene in pensione altrove, a godersi il capitale accumulato in qualche località turistica più calda e più confortevole, né da Miles Bjornstam, il working class hero anarchico, per il quale o la società fa da sola, oppure si mette in mano agli investitori e aumenta la sua dipendenza dal capitalismo, e siccome la società non è né intenzionata, né matura ad autogestirsi, il risultato che è inutile tentare di cambiare le cose. Vida Sherwin, la solerte insegnante sprezzante dei comportamenti asociali dei suoi concittadini, è in realtà la prima ad orchestrare il “tutti contro tutti”, a usare il pettegolezzo come strumento di potere, per dare sfogo a sue segrete frustrazioni. Guy Pollock, il ritroso intellettuale, confessa d’essere contagiato dal Village Virus, cioé detesta la ristrettezza mentale della provincia, ma lo spaventa la competizione metropolitana, a Gopher Prairie almeno si illude di essere qualcuno, non uno qualsiasi tra i tanti. Lo stesso marito di Carol, nel corso di un lungo litigio-confronto con lei (pagine letterarie bellissime) ammette infine di restare in città solo perché lì è una personalità riconosciuta, per quanto professionalmente insidiato da altri medici più scaltri, e perché confida di riuscire a risparmiare quanto è sufficiente per trasferirsi, in un indeterminato futuro, altrove. Nemmeno i provinciali dunque amano la provincia. Nessuno ha davvero intenzione di spendersi per migliorare la situazione. Si sopravvive nell’illusione che basti tirare avanti. E anche chi si sposta, finisce per trasferirsi in un’altra e identica piccola città, nella quale il ricominciare consiste nel continuare la stessa esistenza di prima. L’apparentemente moderno e rampante industriale dell’automobile Percy Bresnahan, omaggiato da tutti, quando passa in città, per aver fatto successo altrove, in realtà, scoprirà più tardi Carol a Washington, è solo un vanitoso che non ha combinato granché, considerato nella capitale come un piccolo trafficante di second’ordine, un arricchito di provincia che posa a imprenditore senza esserlo davvero.
Il mito della sana e virtuosa provincia americana contrapposta alla degenerazione morale delle grandi città, viene corroso da Lewis, così come il mito del pionierismo eroico dei cosiddetti civilizzatori. Lewis detesta anche quel genere di rappresentazione bonariamente comica della vita di provincia, che inanella (come in O. Henry) parlate dialettali e gergali, tipi buffi, caratterizzazioni pittoresche, costruendo un caleidoscopio di maschere multiple e vivaci, che esaltano la diversità nel momento stesso in cui la caricaturizzano. Questa immagine di impronta rurale è per Lewis antica, superata e falsificante. La nuova provincia ha smarrito le sue radici contadine, è il regno dell’omologazione piccolo borghese, il luogo dove la massificazione impera e il consumo si espande e penetra nel profondo con le Ford economiche e i vestiti fatti in serie, dove nel tessuto urbano, l’architettura replica modelli consueti, gli interni si adattano a un’idea del funzionale e dell’essenziale, l’ambizione è quella di possedere un forno moderno piuttosto che un pianoforte, il gusto non è più ricerca personale, ma conformismo. Tale provincia è, per l’America, un freno allo sviluppo civile e culturale, una proposta della mediocrità come unica possibile prospettiva, nella svalutazione dei talenti individuali e nella sopravvalutazione di abitudini indiscusse gabellate per tradizione. Tale provincia non è un modello rigenerante cui ispirarsi, ma una piaga incancrenita. C’è un modo per curare questa piaga o la vera America, la più diffusa, è proprio questa? E quale scenario prepara al paese quest’America tutt’altro che residuale, forse maggioritaria? Lewis tratterà questo tema in un altro e successivo romanzo (It Can’t Happen Here, 1935), più compiutamente politico e di prospettiva. Qui mantiene i suoi propositi di ricognizione attenta dello stato delle cose, negli aspetti più attinenti alla vita quotidiana. Eppure già in questo romanzo rimarca il dato politico della situazione.
Carol non è disposta ad arretrare, non le basta ingentilire la piccola città, né intende coltivare in privato i propri sogni, perché non si tratta soltanto di Gopher Praire, tantomeno della riconferma della propria individuale diversità, si tratta di costruire con coraggio e per tutti una prospettiva futura. Così Carol si esprime in un appassionato monologo rivolto a Guy Pollock, l’intellettuale timido che sembra coltivare qualche grano di consapevolezza oltre che un sincero trasporto amoroso nei suoi confronti:
Io credo che tutti noi vogliamo le stesse cose – tutti insieme, i lavoratori dell’industria e le donne e gli agricoltori e la razza nera e le colonie Asiatiche, e persino un pugno di Rispettabili. Per tutti la medesima rivolta, per tutte le classi che hanno atteso e maturato giusti consigli. Credo che forse vogliamo una vita più consapevole. Siamo stanchi di sgobbare e dormire e morire. Stanchi di vedere solo poche persone in grado di permettersi l’individualismo. Stanchi di differire sempre le nostre speranze alle generazioni successive. Stanchi di ascoltare i politici e i preti e i cauti riformatori (e i mariti!) che ci suggeriscono ‘Stai calmo! Serba pazienza! Aspetta! Noi abbiamo un piano per un’Utopia già pronta; concedeteci soltanto un poco più di tempo e la realizzeremo; fidatevi di noi; noi siamo più saggi di voi.’ Per diecimila anni ci hanno ripetuto questo. Noi vogliamo la nostra Utopia ora – e intendiamo metterci mano. Tutto ciò che vogliamo è – tutto per tutti noi! Per ogni casalinga e ogni scaricatore di porto e ogni nazionalista Hindu e ogni insegnante. Noi vogliamo tutto. Finché non lo avremo, non saremo paghi…
L’obiezione che avanza Guy interrompendola («mia cara, spero proprio che non vorrai unirti alla truppa dei leader sindacali piantagrane»), echeggia in perfetta sintonia con quanto sta scrivendo in quello stesso istante il caporedattore di un giornale di Buenos Aires («Qualsiasi ingiustizia è migliore che vedere il mondo ridotto a un grigio livello di ottusità scientifica»), e un capufficio di New York sta berciando a un suo impiegato («Voi socialisti mi date la nausea! Io sono un individualista. Non mi lascerò tormentare dalla burocrazia e dai sindacati. Vorresti forse sostenere che un barbone vale quanto me o quanto te?»). Ma Carol intende continuare a battersi. Non può, non vuole piegarsi al conformismo della conservazione dello status quo. E non si tratta di eroismo, ma di coscienza politica. Se il suo intellettuale innamorato non lo capisce, finisca di mangiare il suo pop corn e se ne vada, tanto non serve a un bel niente.
Tale coscienza politica, non manca di sottolineare Lewis, è una pulsione sentimentale condivisa da milioni di donne nella «stessa determinazione ad avere coscienza di classe senza saper individuare di quale classe si dovrebbe avere coscienza». Le parole con cui Carol formula le sue istanze «non indicavano soluzioni chiare, esprimevano visioni di una tragica futilità […]. Ma erano sufficientemente precise, e sufficientemente indignate». Il «vogliamo tutto» è il proclama di un’indignazione che trova nelle donne consapevoli il principale soggetto anche se incapace di oggettivarsi in un programma concreto e realizzabile davvero per tutti. Con queste puntualizzazioni, d’altro canto, Lewis non intende mettere alla berlina l’ingenuo velleitarismo rivendicativo della protesta femminile (delle donne più istruite e combattive), casomai ammonire i socialisti a non trascurare tale stato ribelle della coscienza, tale urgenza di cambiamento qui ed ora, a non seppellire questo vitale, energico sentimento sotto un’astratta ragione regolatrice, perché o la coscienza si regge sui soggetti reali, oppure svapora in una progettualità, nei fatti, compromissoria e deludente, cioè in una pianificazione senz’anima. Carol assai più che Liberal, è Radical.
Dopo questa pronuncia politica, il romanzo si diffonde sul bovarismo americano, più contenuto e prudente, meno suddito di visioni romantiche, casomai nutrito di un crescente fastidio femminile per la totale inadeguatezza dei maschi, maturi o giovani non importa, ad assumersi delle responsabilità riguardo non semplicemente alla propria carriera, ai propri talenti, alle proprie aspirazioni, ma alla vita stessa come ricerca della felicità, non unicamente propria, ma di tutti, cioè della felicità condivisa. Uomini in genere timorosi di varcare il limite, pericolosissimo, tra il destino individuale e quello della propria comunità. Inclinare al socialismo equivarrebbe per il cittadino americano medio al varcare la soglia dell’inferno. Il senso della missione collettiva può manifestarsi, in tempi di guerra, come patriottismo, ma ogni proposito di trasformazione sociale radicale comporterebbe un’insanabile frattura con una concezione religiosa, e in quanto tale permanente, della comunità. Si può essere indifferenti o agnostici, ma sarebbe inammissibile venire giudicati atei, figuriamoci proclamarsi tali. I predicatori viaggianti, persino nel corso della Grande Guerra, promettono le fiamme eterne non soltanto ai miscredenti, ma persino ai credenti difformi, come i Mormoni, talmente comunitari da poter essere assimilati ai comunisti, e oltretutto scandalosamente poligami; ma anche agli Avventisti che sacralizzano all’eccesso il Sabato, si ergono a Santi, Eletti e Giusti, dunque si rivelano al fondo neo-ebraici anche se all’apparenza si contrappongono agli ebrei, e per giunta prospettano inquietanti scenari apocalittici. La religiosità media americana, in tutte le sue principali confessioni, dai battisti ai metodisti, si condensa nella proposta del rigore morale, nel rigetto della vanità, del piacere, del desiderio, degli eccessi d’ogni tipo, non certo nella critica, tantomeno nel rifiuto della proprietà privata e della ricchezza personale, intese anzi come premio elargito da Dio in virtù dei meriti acquisiti sul lavoro, né richiede approfondimenti di natura teologica, è una sorta di sentimento religioso condiviso da coltivare in un fondamentalismo più bigotto che biblico. Il presidio morale della chiesa, unito alle “voci” da piccolo borgo, e a una struttura gerarchica fondata sulle famiglie che contano, si manifesta come un apparato repressivo autogestito che non ha bisogno né di corpi di polizia, né garantisce tutela legale. Ne fanno le spese, nel romanzo, i giovani promettenti appena giunti in città, in cerca di emancipazione e vogliosi di rendersi utili. Questi giovani (un figlio di immigrati che si applica alla sartoria, arte giudicata da donne; un’insegnante sportiva che si sforza di essere più partecipe dei costumi sregolati dei ragazzi per educarli dall’interno a una maggiore consapevolezza) vengono considerati doppiamente estranei, perché venuti da fuori e perché ambiziosi e non conformi. Sono, di conseguenza, perseguitati ed espulsi.
Dopo la guerra, inaspettatamente e non per suo merito, ma per occasione, Gopher Prairie conosce un’improvvisa crescita economica. Il prezzo del grano aumenta, la compravendita dei terreni consente anche al marito di Carol di raggiungere in poco tempo uno status economico più elevato, i commerci sulla Main Street prosperano, e piomba in città come novello leader, uno speculatore populista che ne celebra la superiorità persino rispetto a Londra, Parigi, New York, gratificando gli abitanti e il loro senso di appartenenza provinciale ed elevandolo a modello di benessere economico pago di sé. Carol capisce allora che potrebbe restare prigioniera a vita di questa tronfia ristrettezza di orizzonti, e ridotta all’inutilità di un ruolo di moglie e di madre confinata in una domesticità più confortevole ma ancor più desolante perché inerte. E dunque si separa dal marito, se ne va portando con sé il figlio, si trasferisce a Washington e, forte delle sue esperienze nella Croce Rossa durante la guerra, trova facilmente lavoro nelle agenzie governative. Finalmente i suoi orizzonti sono più ampi, la sua indipendenza riconosciuta, il suo contributo più fattivo. Si impegna per il suffragio femminile e per lodevoli cause sociali come la difesa dei detenuti politici, ma, istruita dall’esperienza della provincia, comprende presto che anche nella capitale, il modo più assennato di svolgere il proprio compito è farlo in modo impersonale. In ogni tipo di organizzazione, a ogni livello, nella misura in cui i rapporti personali si fanno più stretti, emergono gli stessi comportamenti da clan caratteristici della provincia. Il vero problema non sono gli individui o la mentalità di questo o di quello, ma la struttura stessa delle istituzioni, ispirata a un modello di correttezza politica.
Non gli individui ma le istituzioni sono i nemici, e affliggono chi vi presta la sua opera tanto più quanto più le serve generosamente. Insinuano la loro tirannia sotto centinaia di guise e nomi pomposi, quali Società Educata, la Famiglia, la Chiesa, Affari Sani, il Partito, il Paese, la Superiorità della Razza Bianca; e l’unica difesa contro di esse, realizzò Carol, è riderne divertiti.
La Main Street non è dunque soltanto provincia. Nella grande metropoli, e più in generale nella società di massa, si riproduce come mainstream, cioè il flusso principale e dominante nel quale si confluisce perdendosi come soggetti reali, e che è legge interna in ogni tipo di organizzazione, pulsione difficilmente resistibile all’uniformità, all’omologazione e al conformismo. L’ironia è un’arma di difesa del singolo, ma, per Carol, non può essere un’arma offensiva, è una sorta di consolazione dello spirito. Il prezzo che si paga è abituarsi, nel flusso, all’impersonalità. Si sa che ci spetta un ruolo, si cerca di svolgerlo al meglio e consapevoli della sua limitatezza, ma la contestazione sociale dei ruoli, intesi come compiti specifici all’interno di una normatività indiscutibile perché intesa come oggettiva, è ancora tutta da costruire. E così Carol si convince infine a tornare a Gopher Praire, dove mette al mondo un secondo figlio, una bambina, e ritrova un rapporto non più conflittuale con suo marito, e scopre che alcuni miglioramenti sono andati avanti senza di lei, per esempio il nuovo edificio scolastico, ad opera della testardaggine operosa e paziente di Vida Sherwin. In città ora tutti riconoscono che le istanze proposte da Carol erano sagge, premonitrici, e avrebbero dovuto essere ascoltate, ma insomma per lei si tratta di un “abbiamo già dato”. Il suo compito lo ha svolto, ora si tratta di vivere anche se per quale futuro non si sa, forse soltanto assecondando il lento progredire delle cose, senza necessità di forzature e senza troppo pretendere dalle persone e dalla loro mentalità che richiede tempi lenti per poter cambiare.
È nel romanzo del 1935 Da noi non può succedere che Lewis espone i possibili esiti per l’America intera del modello provinciale (e non solo) fondato sulla Main Street. Qui si considera uno scenario possibile: la mancata rielezione di F.D. Roosevelt per il secondo mandato, e l’arrivo al potere di un leader populista e autoritario, cioè la fondazione di un fascismo all’americana. Tale fascismo trova il suo leader d’occasione nella persona del senatore Windrip nella quale Lewis addensa e mescola reali figure politiche emergenti all’epoca e nella cui sagoma, come scrive Federico Rampini nella prefazione alla recente edizione italiana, si profila già, oggi più riconoscibile che mai, l’ombra di Donald Trump.
Di fronte a tale eventualità, persino quando è in atto, si tende a minimizzare, nell’opinione pubblica, in nome del qui non può succedere. Nessuno può davvero credere che l’America possa sprofondare in tale degrado della coscienza sociale e individuale e rinnegare le proprie fondamenta democratiche. Eppure accade (nel romanzo, ma in realtà si verifica l’esatto contrario: Roosevelt sarà l’unico presidente americano che resterà in carica per quattro mandati, imprimendo l’impronta dell’America democratica che rafforzerà l’idea del qui non può succedere, fino al punto da oscurare le contraddizioni profonde dello sviluppo americano, e facendo trionfare la fallace idea dell’American Dream). Resta il fatto che la distopia prospettata da Lewis illumina con straordinaria lucidità e preveggenza il sussistere di un fascismo strisciante che trova i suoi punti d’appoggio nell’America del Mid-west e più in generale della provincia profonda, nelle sette religiose, nel pionierismo della conquista e nella celebrazione della legge del più forte, nel culto delle armi, in un individualismo cementato dal senso di appartenenza a piccole comunità omogenee, e in uno sviluppo mediatico (la radio, in questa fase) guidato e controllato dai grandi gruppi d’interesse. I segnali indubitabili di questo fascismo stanno nel nazionalismo enfatico, nel disdegno dei diritti umani, nell’identificazione di un nemico esterno-interno (gli stranieri, gli immigrati, gli ebrei), nel militarismo, nel sessismo esasperato, nel razzismo suprematista, nella propaganda mediatica che traduce la politica in spettacolo e in ostentata e continua diffusione del falso, nella religione usata come strumento politico, nelle corporazioni, nell’anti-sindacalismo, nel disdegno per gli intellettuali e le arti, nell’ossessione del crimine e della pena, nel nepotismo e nella corruzione.
Di fronte a questo quadro, nel romanzo di Lewis, liberali, socialisti, comunisti, anarchici e minoranze oppresse, si ritrovano tutti, di fatto, opposizioni, e dunque spinti a collaborare, al di là delle diversità ideologiche e degli interessi, in una Nuova Resistenza, eppure, nel sociale, tale opposizione è più individuale (ed esemplare) che collettiva (e davvero praticata con spirito collettivo). Lewis dedica pagine tanto ironiche quanto amare al socialismo americano (ma anche qui, le riflessioni vanno ben al di là dell’America). Alle sue immaginate, ma tutt’altro che immaginarie elezioni, si presentano anche dei candidati comunisti, ma divisi in ben sette partiti. Così scrive Lewis:
Se si fossero coalizzati, avrebbero potuto raggiungere novecentomila voti, ma avevano evitato quella volgarità borghese per degli entusiastici scismi, così adesso si contavano il Partito Comunista, il Partito della Maggioranza, il Partito della Sinistra, Il Partito Trotzkista, il Partito Cristiano Comunista, il Partito dei Lavoratori e un qualcosa che, senza tanti giri di parole, si chiamava il Partito Comunista Nazionalista Patriottico Post-Marxista Americano2.
La differenza tra socialisti e comunisti, a parere del protagonista, il coraggioso giornalista d’opposizione Doremus Jessup, non sta nel fatto che i primi sostengano la proprietà pubblica dei servizi, mentre i secondi quella, integrale, dei mezzi di produzione, e neppure nel ricorso o meno alla lotta violenta. Tali differenze per Doremus sono «fesserie».
La vera differenza è che voi comunisti siete al servizio della Russia. È la vostra Terra Santa.
In altre parole, già negli anni Trenta, si configura uno scenario da guerra fredda e parte non irrilevante della sinistra americana, aderendo al polo opposto, si indebolisce esponendosi all’accusa di anti-americanismo. Altra questione discriminante:
Un’altra cosa: io sono un intellettuale della classe media. Non avrei mai pensato di definirmi con un’espressione così stupida, ma visto che l’avete coniata voi, fingiamo di accettarla. La mia classe comunque è quella, ed è quella che mi interessa. I proletari sono forse gente per bene, non ci piove, ma di certo non penso che gli interessi degli intellettuali piccolo-borghesi siano gli stessi dei proletari. Loro vogliono il pane. Noi vogliamo – mi tocca dirlo – la torta! E quando hai un proletario abbastanza ambizioso da volere la torta, ebbene, qui in America diventa un intellettuale della classe media più in fretta che può… se può!
Karl Pascal, l’amico comunista, gli replica che «il 3% della popolazione possiede il 90% della ricchezza», e Doremus ribatte che…
…gran parte degli intellettuali appartiene al 97% di quelli rimasti al verde… molti attori, insegnanti, infermiere e musicisti non sono pagati molto meglio di macchinisti o elettricisti, perciò i loro interessi sono gli stessi. Non è quanto guadagni ma come lo spendi che determina la tua classe sociale… se preferisci funerali sontuosi o una biblioteca piena di libri. Sono stufo di dovermi scusare per non avere il collo sporco!
Sono «castronerie», come commenta Karl? In realtà nelle argomentazioni di Doremus risuonano accenti critici piuttosto seri: la celebrazione di un proletariato mitizzato finisce per oscurare la proletarizzazione del ceto medio, cioè proprio l’appartenenza al 97% degli esclusi, e la propensione a considerare l’appartenenza di classe come dato d’origine e di nascita, svaluta gli elementi di coscienza e di visione del futuro.
È in base a tali elementi che Doremus si definisce Liberal. Non si tratta affatto di un «credo insipido» da cui si debba essere purificati educativamente, magari in campo di concentramento, per aderire alla «nuova era del controllo economico autoritario». Doremus imputa tale distorsione caricaturale del liberalismo a intellettuali che considerano il parlamento «un pantano» e predicano l’affidarsi fiducioso e fideistico al Capo come rappresentante supremo del popolo, perché tanto il popolo non chiederebbe altro che d’essere guidato (The Art of Being Ruled, per citare un altro Lewis, Wyndham) e individua negli schieramenti oppositivi (fascismo e comunismo) una comune deriva totalitaria. Se in presenza di un fascismo americano al potere i Liberal non possono che essere alleati di socialisti e comunisti, se essi si trovassero in Russia sarebbero parte del variegato mondo dei dissidenti.
Quali sono i tratti della vera coscienza Liberal e come possono essere coniugati radicalmente? Sinclair Lewis non compone un Manifesto, ma provo, dall’insieme del suo romanzo, a definire i tratti di tale coscienza Liberal, che soprattutto nelle fasi di autoritarismo rampante, diventa Radical. Essa è:
1. Post-puritana perché la sua morale non ha fondamenta rigide, è tollerante, duttile, relativa alle circostanze e alle sensibilità individuali.
2. Post-illuminista perché non confida nel dominio della Ragione, consapevole dell’umana fragilità e dell’impredicabilità della Storia.
3. Post-progressista perché non contempla un cammino evolutivo inesorabile e oggettivo, tantomeno provvidenziale, in quanto il peggio può sempre venire ed è tale probabilissima evenienza che va sventata.
4. Post-capitalista perché diffida dei trust, dei magnati, dell’economia gestita dall’alto e dai grandi gruppi, ed è invece fautrice di uno sviluppo lento, decentrato, prodotto e sperimentato dal basso e del quale le minoranze (donne, ebrei, neri), e gli individui di buona volontà, dotati di coscienza e senso pratico, sono i soggetti attivi determinanti.
5. Post-imperialista, decisamente pacifista e anti-militarista, diffidente di ogni Potere e di ogni Volontà di Potenza, assai poco propensa alla Violenza Levatrice della Storia, quand’anche tale violenza sia giustificata e necessitata.
6. Post-utopistica, perché alla ricerca della perfezione e della verità, preferisce la ricerca della felicità attuale, e ai desideri il realismo del concretamente possibile, per modesto che sia, qui ed ora. Lo stesso American Dream le pare falso, illusorio e insidioso.
7. Post-rivoluzionaria, perché propone come orizzonte politico, già negli anni Trenta, la Resistenza attiva e militante, senza barriere ideologiche, in una prospettiva di Movimento aperto e permanente.
Tutti questi elementi correlati rendono la proposta Liberal americana difficilmente interpretabile e/o condivisibile sia dal liberalismo europeo, incline al conservatorismo con derive apertamente reazionarie e incardinato sugli interessi privati, sia dal socialismo europeo che confida nella rigenerazione programmata, riformista o rivoluzionaria, affidata alla centralità dello Stato e/o alla conquista del “cuore dello Stato”, prospettiva, quest’ultima, piuttosto illusoria, per il semplice motivo che lo Stato non ha cuore, tantomeno può essere concepito come il cuore dello sviluppo.
La confusione europea nei confronti della prospettiva Liberal americana, tanto più se sconfinante nel Radical, perdura: la destra la considera pericolosamente incline ad atteggiamenti libertari, la sinistra la considera insensibile alla tutela degli interessi materiali di classe e sterilmente spontaneista. La novità costituita dall’identità Liberal e/o Radical americana viene insomma ricondotta in schemi di origine ottocentesca, mal riproposti e ideologicamente irrigiditi agli inizi del Novecento, da cui destra e sinistra del Vecchio Mondo faticano tuttora ad affrancarsi. Tra tutti gli autori americani proposti o riproposti in Italia nel dopoguerra, Sinclair Lewis è il meno pubblicato, il meno letto, il meno indagato. Nessun suo scritto figura nell’antologia Americana curata da Elio Vittorini.
S. Lewis, Main Street. The story of Carol Kennicott, Jonathan Cape, London 1921.
S. Lewis, Da noi non può succedere (traduzione di Teodoro Guidalberti), Passigli, Firenze 2016.